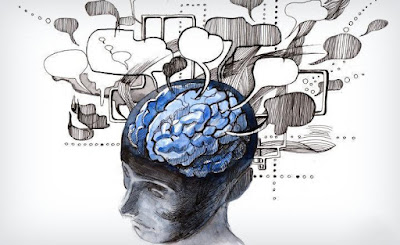Utilitarismo
L’utilitarismo è una teoria etica che valuta la moralità delle azioni in base alle conseguenze che producono, in particolare rispetto alla felicità o al benessere che generano. In altre parole, un’azione è giusta se produce la massima felicità per il maggior numero di persone.
Idee fondamentali
1. Consequenzialismo
- Il bene o il male di un’azione dipende dalle sue conseguenze, non dalle intenzioni o dalle regole.
2. Principio di utilità
- Il criterio supremo dell’etica è la massimizzazione dell’utilità, intesa come piacere, felicità o assenza di sofferenza.
3. Universalismo etico
- Ogni individuo conta allo stesso modo: la felicità di ciascuno ha lo stesso peso morale.
Autori principali
🔹 Jeremy Bentham (1748–1832)
- Fondatore dell’utilitarismo classico.
- Formula il calcolo edonistico: propone di misurare la felicità prodotta da un’azione secondo criteri come intensità, durata, certezza, prossimità, fecondità e purezza.
- Slogan famoso: “Il massimo della felicità per il massimo numero di persone.”
🔹 John Stuart Mill (1806–1873)
- Raffina l’utilitarismo di Bentham, distinguendo tra piaceri superiori (intellettuali) e piaceri inferiori (fisici).
- Sottolinea che qualità e non solo quantità del piacere devono essere considerate.
- Difende l’utilitarismo anche in ambito politico, come base del liberalismo e della tutela delle libertà individuali.
🔹 Henry Sidgwick (1838–1900)
- Cerca di armonizzare l’utilitarismo con l’etica del dovere kantiana, dando una formulazione più sistematica del principio di utilità.
Utilitarismo contemporaneo
🔹 Peter Singer
- Applica l’utilitarismo alle sfide etiche contemporanee: diritti degli animali, altruismo efficace, etica ambientale, bioetica.
- Sostiene che ignorare la sofferenza degli animali o dei poveri del mondo è moralmente ingiustificabile.
🔹 Utilitarismo negativo
- Versione proposta da Karl Popper e altri: l’obiettivo non è massimizzare la felicità, ma ridurre al minimo la sofferenza.
Critiche all’utilitarismo
-
Problema dei diritti individuali
- Il bene della maggioranza potrebbe giustificare gravi ingiustizie verso i singoli (es. sacrificare una persona per salvare molte).
-
Difficoltà del calcolo
- È spesso impossibile prevedere tutte le conseguenze e quantificare felicità e dolore.
-
Imparzialità eccessiva
- Trattare tutti allo stesso modo può ignorare relazioni personali e doveri speciali (es. verso familiari o amici).
Conclusione
L’utilitarismo è una delle teorie morali più influenti della filosofia occidentale, soprattutto per la sua praticità e il suo orientamento al bene collettivo. Ha contribuito in modo determinante alla nascita dell’etica pubblica moderna e rimane centrale nei dibattiti su giustizia sociale, diritti, politiche sanitarie, ambientalismo, IA e bioetica.